
La luce forte, chiarissima e virginea dell’alba splendeva sopra i vapori umidi che la terra del borgo, fradicia, soffiava verso l’alto.
L’aria appariva come una pellicola sottile che perdendo progressivamente la sua opacità lattiginosa, iniziava a rivelare i dettagli più minuti di quella mattina nascente.
Gli alberi di Piazzale Muschiolini, lavati dalla liquida carezza della notte appena trascorsa, sembravano stirarsi, allungando verso il nuovo sole le loro fitte fronde, di un bel verde rasserenante.
I giardini del grande parco – si diceva che ospitassero un guardone in ogni arbusto – andavano intanto animandosi: un arciere cominciava a strigliare per benino il cavallo e contemporaneamente il cavallo, un animo schizzinoso, rimpiangeva di non poter fare altrettanto all’arciere, il cui lezzo, giorno dopo giorno, andava facendosi sempre più selvatico e insopportabile.
Partivano carri gonfi di merci verso le stazioni di posta che costellavano le strade di campagna che, regolari come raggi di ruota, dal cuore di Littoria andavano ad irradiarsi in ogni direzione.

Nel fontanile di Piazza della Palla le lavandaie si erano già schierate nell’ordine di posto che avevano conquistato negli anni.
Tuffavano i panni in acqua e li strizzavano, scherzavano infuocando le loro schermaglie di parole piccanti, sfottenti e allusive e si sgangheravano strillando senza grazia l’unico coro che conoscevano:
“Bella Littoria”
Come ogni mattina, alla stessa ora, caracollando su Fiche, il suo cavallo favorito, fece la sua apparizione Bartolomeo Zaccheoni, Podestà del borgo e Capo delle Corporazioni dei Mattonieri e dei Metrovagonisti.

Sfilando alle spalle delle donne chine sulla fontana, esaminò le terga di ognuna di esse con occhio esperto e sportosi dalla cavalcatura, diede una gran pacca alle rotondità di quella che lo aveva più convinto.
“Ma, signore!!”
– protestò la bella lavandaia drizzandosi di botto e portandosi una mano alla gota arroventata.

La risposta del Podestà fu tutta nel suo sorriso speciale, l’arma in grado di convincere i sudditi a sacrificare i loro primogeniti, come stava per fare Abramo.

La celebre smorfia si trattenne ancora un istante sul viso dell’uomo prima che egli ripartisse, allontanandosi in direzione del porticato del Circolo Borghigiano dove come al solito, essendo lui piuttosto abitudinario, lo attendeva la consueta seduta di Baccarà.
Sempre che sul momento, seguendo un ghiribizzo improvviso, non optasse invece per una partita a Zara, il suo gioco di dadi favorito.

Fiche trottava senza fretta, conosceva bene la via, che si andava intanto affollando di gente di vario ceto.
Un plotoncino di barattieri camminava frettoloso, anch’essi erano diretti al Circolo dove, autorizzati dal Podestà previo il pagamento mensile di una discreta manciata di ducati, esercitavano i mestieri legati al gioco d’azzardo.
Cani rognosi inseguivano tre o quattro porcelli sfuggiti alla fanga dei loro recinti, mentre un grumo di buffoni faceva pubblici giochetti con clave e sfere di legno, ed eseguiva saltellini che parevano divertire moltissimo il pubblico che gli si era radunato intorno a cerchio.

Mocciosi scalzi e sporchi, snocciolati senza controllo in ogni angolo della piazza, tiravano calcetti a fratellini minori che gli si appigliavano frignanti alle gambe e nel farlo ridevano forte coi dentini a scacchiera.
Poco distante, sotto la torre civica, un manipolo di giullari di tipo differente, tutti rigorosamente in tenuta scura, teneva a bada le poche idee tappandosele in capo con dei curiosi berretti a forma di tortino, sormontati da un corto laccetto.
Impolverandosi progressivamente, alternavano esercizi ginnici e rapidi piegamenti sulle braccia a buffi, plateali saluti col braccio teso.
Rimaneva un mistero come la gente che vagava per le strade del borgo tenendo dietro ai propri mestieri e affanni o che esercitava con scrupolo la nullafacenza, ovvero la stessa cerchia che si sbellicava per i patetici saltelli dei buffoni, non trovasse sommamente comico lo spettacolo di questi altri giullari, riservandogli al contrario la noncuranza che si attribuisce alle cose normali.
Ma tant’è:
erano cose che succedevano unicamente a Borgo Littoria, sue peculiarità.
Col passar delle ore anche negli interni la vita si destava.

Nella penombra densa di un piccolo ambiente ricavato nell’androne del Palazzo del Capitano del Popolo, Brandimarte Frangiflutti, direttore della Corporazione dei Pubblici Banditori, con la testa surriscaldata e sudando visibilmente per le ore in cui aveva dovuto sforzare la memoria, ripassava l’ode da dedicare, in ore diverse naturalmente, sia al podestà Bartolomeo Zaccheoni che al Console Percivalle Strazzone. I due notoriamente si detestavano e a ciò si doveva la cautela del Direttore di declamare gli stessi versi in ore e contesti differenti. Per l’ennesima volta, gorgheggiando teatralmente, spronò la voce all’impresa:
“Vedut’ho la lucente stella diana,
ch’apare anzi che ’l giorno rend’albore,
c’ha preso forma di figura umana;
sovr’ogn’altra me par che dea splendore…”
In un angolo scuro della stessa stanza, due banditori ad esso sottoposti, dandosi di gomito, ghignarono all’indirizzo di Frangiflutti e uno di loro, facendosi schermo con una mano sussurrò all’altro con la voce roca, tipica dell’usura professionale: ”Questa non è sua, avve almeno cent’anni: a Guinizelli Guido la carpì.
Ma in questa santa gnoranzia nostra borghigiana, chi voi che se n’avveda e se n’adonti!”.
Fuggiva il tempo portando il mattino a età matura: si faticava rari e sparsi nei campi e si formicolava fitti stipati nel borgo.
Tra le navate della Cattedrale di San Marco Evangelista erravano con la testa volta in alto alcuni campagnoli spediti dal valvassore al borgo per servizi. Smarrivano in estasi il senno al cospetto delle maestose vetrate policrome. Piegavano le gambe, colpiti dalle figure come da una folgore, e particolarmente si inebetivano sotto una di quelle vetrose rappresentazioni nella quale Messer Muschiolini, il cavaliere intemerato, benediva i frumenti sotto l’occhio compiaciuto del Signore Iddio.

Tanta era l’impressione delle vetrate che anche uscendo dalla chiesa i villani seguitavano a calpestare nuvole.
Non lontano dal sacro edificio la Locanda Mimisi teneva i suoi tavolacci a stagionare al sole, perennemente presidiati dai notabili locali, troppo signori per tenersi occupati altrove.
Conclusi i loro traffici senza sprecar carta, essi si davano da quel momento in poi a guardare la via percorsa da genti e carri.
Tenevano un velo poggiato alla bocca, non per vezzo ma per respingere la polvere che senza sosta ne veniva sollevata.
Cianciavano di nulla,
commentavano le ultime gride urlate dai pubblici banditori o le fogge di qualche madonna al braccio dell’austera e occhiuta madre.
Ma quel giorno soprattutto respiravano sollevati per non essere stati tradotti anch’essi in reclusione dalla mano, fattasi improvvisamente nemica, della legge.
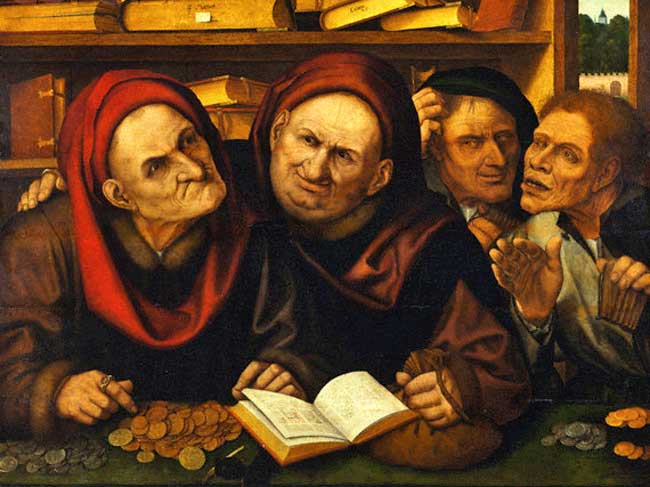
Per quanto potesse sembrare irreale come la rinunzia all’arrosto in un frate gaudente, un siffatto abominio poteva accadere, anzi, era accaduto.
E novellavano del loro vecchio compare, l’ex Capitano del Popolo Pascale Straccetto, che languiva infermo nello Spedale de’Retrocessi in attesa d’esser condotto in gabbia.

D’un tratto, non si capì bene come fu, qualcuno, uno di loro o forse no, un tizio nella via, disse un motto sbagliato, una mezza accusa o fece un lazzo e presta sorse una rissa.
Si accapigliavano a mucchi, si scalciavano, s’artigliavano per i ghigni: tutto era un turbine. I nasi presero a colar sangue, volarono alte e mozze le grida e molti occhi, pestati, annerirono.
La zuffa, nascosta dal polverone, scomparve alla vista della gente, molta della quale, quella che non si era buttata allegra a menar botte anch’essa, s’era data invece prudentemente a gambe.
Lo spiazzo dinanzi alla maggior locanda di Littoria era divenuto in un amen un campo di battaglia, rotolavano i corpi avvinghiati e svolazzavano bestemmie.
Si contavano già decine quelli che presi bene a botte e traditi dalle gambe, sonnecchiavano faccia a terra, quando finalmente, con un assordante clangore di armature e spade, gli scherani del podestà, poco rassicuranti e ipertricotici, irruppero sciabolando nel teatro della rissa …

ANNO DI GRAZIA 2018
Tarallo:
“Mi pare di non aver trascurato niente Dottore, il sogno era tutto qui. A questo punto, come succede sempre con questo genere di incubi, mi sono svegliato quasi volando, con le gambe che scalciavano e la bocca asciutta asciutta, secca dalla sete. Del resto, con tutta quella polvere… Che le dicevo? Comincio a preoccuparmi: è la seconda volta che mi capita una cosa così ed una terza non sarebbe assolutamente accettabile: non vorrei sognare la Littoria del neolitico e beccarmi una clavata, già ce ne è troppo di neolitico nella città di oggi e in questo campanilismo agonistico”.
Dott. Emmanuel Cervellenstein, psicanalista:
“Io, me ne deve dare atto, l’avevo avvertita di tenere a bada le sue sbornie social, ed in particolare l’avevo consigliata di tenersi lontano chilometri e chilometri dalle pagine falso romantiche del genere “I love Littoria”, “Littoria nel pancreas” o roba simile. Ma come? Con una città con poco e discutibile passato, loro fanno progetti per quel passato!
Lo diceva sempre il povero Flaiano – ricorda? – che c’è della patologia nella mania destrorsa del bel tempo andato, degli anniversari, delle celebrazioni, degli anniversari degli anniversari.
Continui a non ascoltarmi e lei Tarallo finirà per precipitare indietro.
Lei verrà sbalzato in un passato sempre più remoto e sempre più fasullo.
Un passato stravolto dalla chirurgia estetica politica: il brutto inguardabile passato, taciuto e nascosto da un bel passato presentabile, rassicurante, giusto, un passato nuovo di zecca!
Ma falso, falso come una nota intonata di Jovanotti.
Non corra più dietro a chi ama il passato, se ne tiri fuori:
resti la prego tra quelli che il passato, semplicemente, lo conoscono”.
Lallo Tarallo, giovane sin dalla nascita, è giornalista maltollerato in un quotidiano di provincia.
Vorrebbe occuparsi di inchieste d’assalto, di scandali finanziari, politici o ambientali, ma viene puntualmente frustrato in queste nobili pulsioni dal mellifluo e compromesso Direttore del giornale, Ognissanti Frangiflutti, che non lo licenzia solo perché il cronista ha, o fa credere di avere, uno zio piduista.
Attorno a Tarallo si è creato nel tempo un circolo assai eterogeneo di esseri grosso modo umani, che vanno dal maleodorante collega Taruffi, con la bella sorella Trudy, al miliardario intollerantissimo Omar Tressette; dall’illustre psicologo Prof. Cervellenstein, analista un po’ di tutti, all’immigrato Abdhulafiah, che fa il consulente finanziario in un parcheggio; dall’eclettico falsario Afid alla Signora Cleofe, segretaria, anziana e sexy, del Professore.
Tarallo è stato inoltre lo scopritore di eventi, tra il sensazionale e lo scandaloso, legati ad una poltrona, la Onyric, in grado di trasportare i sogni nella realtà, facendo luce sulla storia, purtroppo non raccontabile, di prelati lussuriosi e di santi che in un paesino di collina, si staccavano dai quadri in cui erano ritratti, finendo col far danni nel nostro mondo. Da quella faccenda gli è rimasta una sincera amicizia col sagrestano del luogo, Donaldo Ducco, custode della poltrona, di cui fa ampio abuso, intrecciando relazioni amorose con celebri protagoniste della storia e dello spettacolo.
Il giornalista, infine,è legato da fortissimo amore a Consuelo, fotografa professionista, una donna la cui prodigiosa bellezza riesce ad influire sulla materia circostante, modificandola.
Lallo Tarallo è un personaggio nato dalla fantasia di Piermario De Dominicis, per certi aspetti rappresenta un suo alter ego con cui si è divertito a raccontarci le più assurde disavventure in un mondo popolato da personaggi immaginari, caricaturali e stravaganti


