
Ho già scritto in più di un’occasione che accanto agli incontestabili geni della letteratura, che vanno amati necessariamente per l’apporto insostituibile che hanno saputo dare all’arte letteraria, personalmente ho sempre avuto una passione palese per gli “irregolari”, per le teste balzane, per gli autori capaci di straordinarie quanto isolate levate di ingegno, per gli scrittori, insomma, che col loro talento hanno trovato sapori imprevisti da regalare al gran minestrone della Storia della Letteratura.
Di qualcuno di essi abbiamo già parlato qui, nello spazio della nostra rivista, ma volendo incrementare questo percorso di incontri insoliti, non posso non presentarvi una figura di scrittore come quella di Ambrose Bierce, un autore che si è sempre tenuto distante dal prevedibile e perfino dal sensato, regalandoci un vero cesto di delizie insaporite dal gusto acre del sarcasmo.

Ambrose Gwinnett Bierce nacque ad Horse Cave Creek, il 24 giugno 1842, decimo figlio di una famiglia numerosa.
Tutti i fratelli erano stati battezzati con nomi inizianti per a: Abigail, Amelia, Ann, Addison, Aurelius, Augustus, Almeda, Andrew, Albert, Ambrose.
I genitori, Marcus Bierce e Laura Sherwood, erano membri di una comunità religiosa vicina ai pentecostali e tutta la famiglia economicamente navigava in cattive acque.
A soli quindici anni, stanco della povertà in cui viveva e impaziente di dare una scossa al destino mediocre che con ogni probabilità gli era riservato, Ambrose andò via di casa, vagabondando per la nazione e campando di espedienti.
Fu uno zio benestante, Lucius Bierce, fratello minore del padre, avvocato e sindaco di Akron, nell’Ohio, a rassettargli l’esistenza prendendolo sotto la sua ala protettrice ed avviandolo agli studi.
Lo fece iscrivere al Kentucky Military Institute ed il fatto che in quella scuola militare Bierce avesse imparato anche la cartografia lo favorì nel momento in cui, nel 1861, decise di arruolarsi volontario nell’esercito: lì ebbe infatti mansioni di topografo.

Con la guerra civile in corso, l’esistenza del giovane non prese certo una piega meno incerta e drammatica.
Gli toccò combattere infatti, e lo fece con grande coraggio, nelle più sanguinose battaglie di quel conflitto, quelle rimaste nella Storia per l’enorme carneficina in cui si risolsero: Shiloh, Chickamauga, Pickett’s Mill e molte altre.
Una ferita alla testa gli fu quasi fatale e, per l’eroismo dimostrato, si guadagnò sul campo il grado di Tenente.
Nel dopoguerra venne promosso onorificamente a Maggiore, saltando, probabilmente per un errore, il grado di Capitano.
L’esperienza della guerra lo vaccinò definitivamente contro il patriottismo, ed il racconto minuzioso dei corpi macellati dei caduti di entrambi gli schieramenti sarà l’ingrediente più forte del realistico resoconto che ne fece molti anni più tardi in “What I saw of Shiloh”.

Al termine del conflitto Bierce iniziò una vita decisamente avventurosa facendo per anni ogni genere di mestiere.
Il primo di questi fu l’Agente del Tesoro in Alabama, addetto a controllare furti e ammanchi sulla requisizione delle tonnellate di balle di cotone sottratte all’esercito sconfitto del Sud.
Troppo onesto per reggere a lungo quel ruolo riprese prima a fare il topografo, poi l’ispettore di fortini militari nello Utah, nel Montana e nel Wyoming, avendo a che fare con mille situazioni che rendevano quella vita più che accidentata: scontri con i Sioux, con ex soldati confederati convertiti al crimine comune e con cacciatori di taglie dalla pistola troppo facile.
Un‘offerta che gli venne fatta dall’Esercito perché prolungasse la ferma venne da lui respinta con garbata fermezza.
Nel 1867 Bierce, dopo quasi un decennio di guerra e peregrinazioni avventurose, si ritrovò a San Francisco.
Poco gli era rimasto in mano: era senza soldi e senza lavoro.
Fu così quasi per caso, oltre che per disperazione, che iniziò una carriera di giornalista al San Francisco News Letter, dove all’inizio trattò soprattutto la cronaca nera.
Il suo acuto senso di giustizia lo portò a interpretare il ruolo di cronista difendendo coraggiosamente le minoranze, quella irlandese e soprattutto quella cinese, dagli oltraggi razzisti.
Immediatamente rivelò le doti di anticonformismo e di sarcasmo acuminato che saranno alla base della sua cifra stilistica:
“Il cadavere di una donna cinese è stato ritrovato martedì mattina riverso sul marciapiede in una posizione assai scomoda, le cause della morte non possono essere accertate con sicurezza, ma poiché aveva la testa spaccata i dottori pensano sia deceduta per un attacco di cristianesimo galoppante del tipo maligno della California”.
L’humour nero, il cinismo intelligente ed il suo piglio ferocemente anticlericale diventarono nel giro di poco tempo proverbiali.
Bierce divenne una firma affermata e temuta ed i suoi attacchi a politici, uomini di malaffare e imprenditori, lo misero in qualche rischio, se è vero che, a quanto riportavano le cronache dell’epoca, usava portare una pistola con sé quando andava in giro.

Bierce era uomo attraente, alto, muscoloso, con lunghi capelli biondo sabbia, occhi azzurri e baffoni spioventi su un incarnato rosa quasi femmineo.
Curava meticolosamente sia l’abbigliamento, sempre elegante, che l’igiene personale.
Aveva l’attenzione costante delle signore, ma lui per molto tempo ostentò una certa sulfurea misoginia.
Nel 1871 sposò Mary Ellen Mollie Day, una ragazza bella e ricca, e si concesse un lungo viaggio di nozze a Londra dove cercò senza troppo successo di accreditarsi come scrittore.
Il suo matrimonio, che si concluse con un divorzio nel 1904, già dal 1888 poteva dirsi fallito visto che Bierce e la moglie in quell’anno si separarono di fatto.

Dei tre figli avuti dalla coppia, soltanto la terzogenita Helen sopravviverà ai genitori. Day, il primogenito, morì omicida e suicida ancora adolescente per faccende amorose e Leigh, l’altro maschio, venne a mancare giovanissimo per una polmonite.
La carriera di Bierce come giornalista affermato lo aveva portato a scrivere per molti giornali e riviste come “The argonaut” o il “Wasp”.
Per quest’ultimo aveva iniziato a pubblicare a puntate il “Dizionario del diavolo”, la sua rivisitazione in chiave satirica e cinica delle definizioni contenute nei vocabolari e che era destinata a diventare la sua opera più celebre.
La satira era del resto il suo territorio prediletto ed anche teoricamente Bierce ne rivendicava la preminenza sull’umorismo.
Arrivò addirittura a pubblicare un piccolo saggio, “Wit and Humor”, in cui sosteneva le ragioni della satira, le stesse ragioni che stavano alla base delle sue schermaglie col collega e amico/nemico Mark Twain.
Scriveva:
“l’humor è tollerante, tenero, fatto di ridicole carezze; la satira invece pugnala, chiede scusa e rigira il pugnale nella ferita”.
Collezionava soprannomi che alludevano alla sua natura di cinico capace di feroce sarcasmo.
Il più famoso di tutti, quello che gli restò perennemente attaccato addosso fu quello di “bitter” (amaro), ma il suo preferito tra i tanti che gli vennero affibbiati, era quello che lo individuava come: ”l’uomo più perfido di San Francisco”.
Nel 1887 lo scrittore lasciò il lavoro al Wasp, ritirandosi in una piccola casa di campagna ad Oakland, vicino a dove viveva suo fratello Albert.
Memorabile fu la storia legata al suo passaggio al “San Francisco Examiner”.
Un pomeriggio un giovane poco più che ventenne “la cui intera personalità suggeriva estrema diffidenza” – scriverà Bierce in seguito rievocando l’episodio – bussò alla sua porta.
Ambrose lo ricevette, invitandolo a chiarire le ragioni della sua visita. “Sono dell’Examiner di San Francisco.” – rispose il giovane.
“Ah – borbottò Bierce – venite da parte del Signor Hearst”.

Il ragazzo guardandolo in volto con occhi innocenti di un blu intenso gli rispose: “Io sono il Signor Hearst”.
Fu l’inizio di un sodalizio lunghissimo col magnate progressista della stampa ed infiniti furono da lì in poi i bersagli che Bierce colpì con la sua penna arroventata, senza mai timore di buttarsi in battaglie perdenti, senza cedere mai alla prevedibilità e al conformismo.
Parallelamente a quella di giornalista proseguiva una carriera di scrittore che ebbe i suoi picchi narrativi soprattutto nel racconto fantastico, in quello del sovrannaturale e in quello del terrore.
Perse progressivamente le persone care, come si è detto, e nel 1905 morì anche sua moglie che, nonostante la separazione, rimaneva pur sempre una figura di riferimento per lui.
A settant’anni, assalito da sempre più frequenti e gravi attacchi d’asma, iniziò ad essere insofferente all’idea di un suo lento, definitivo declino fisico e si dispose ad affrontare la sua ultima avventura.
“Questa rivoluzione in Messico mi interessa:
voglio scendere giù a vedere se i messicani sparano bene”,
disse agli amici e colleghi di Washington prima di lasciare per sempre la città.
Dopo un giro di natura nostalgica sui luoghi dove aveva combattuto le tremende battaglie della Guerra Civile, si avviò dunque verso il Messico scosso dalla rivoluzione di Zapata e Pancho Villa.

Le tracce di Ambrose Bierce si persero nel nulla ed il mistero della sua fine non fu mai risolto.
Alle voci che lo volevano fucilato per essere stato scambiato per una spia, voci che mai trovarono un riscontro, si contrapposero quelle che sostenevano che non fosse mai giunto in Messico e che si fosse suicidato in qualche grotta nascosta per non essere mai ritrovato e consegnato alla leggenda.
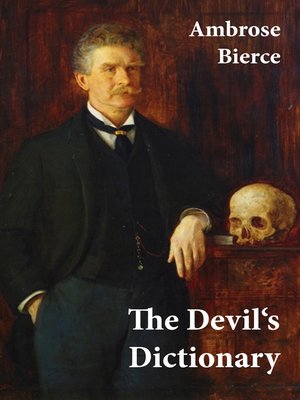
Dal “Dizionario del Diavolo”:
Acefalo (agg.). Imbarazzante condizione di quel tal crociato che cercò di ravviarsi i capelli qualche ora dopo che la scimitarra di un saraceno gli era passata – come riferisce De Joiville – attraverso il collo.
Acrobata (s.m.). Uomo che si rompe la schiena per riempirsi la pancia.
Aiutare (v. tr.). Aumentare il numero degli ingrati.
Amore coniugale. Erotismo che viene perversamente deviato verso la propria moglie.
Apatico (agg.). Sposato da sei settimane.
Applauso (s.m.). L’eco di un luogo comune.
Bellezza (s.f.). Il mezzo con cui una donna conquista l’amante e terrorizza il marito.
Bruttezza (s.f.). Dono che gli dei fanno a certe donne, e che rende possibile la virtù senza l’esercizio dell’umiltà.
Calunniare (v. tr.). Parlare di un uomo e giudicarlo quando lui non ti può mettere le mani addosso.
Cannone (s.m.). Strumento impiegato per la rettifica dei confini nazionali.
Canonizzare (v. tr.). Prendere un peccatore morto e tirarne fuori un santo.
Casa (s.f.). Costruzione cava eretta per essere abitata da uomini, topi, scarafaggi, mosche, zanzare, pulci, bacilli e microbi.
Colpevole (s.m.). Trattasi sempre di un’altra persona.
Dentista (s.m.). Un prestigiatore che, dopo aver messo del metallo nella tua bocca, tira fuori monete dalle tue tasche.
Dissotterratore di cadaveri. Dicesi di chi deruba i vermi e fornisce ai giovani medici ciò che i loro colleghi più anziani avevano fornito al becchino.
…….. continua (se vorrete)
Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.
Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.
Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.
Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.
Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.
Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:
“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.


