
Ci sono alcuni libri, e ne trovi molti se sei un lettore assiduo, che non si lasciano dimenticare, che possiedono una forza ed una incisività tali da strapparsi le pagine di dosso e stampartele in testa.
Sono quelli la cui lettura si traduce in un evento straordinario, una vera e propria avventura, un viaggio tempestoso e inaspettato.
I grandi libri, anche quelli la cui qualità, ben prima di aprirli, ti si annuncia di lontano, ti sorprendono sempre, ed il discorso riguarda tanto più, quei romanzi di cui, al contrario, sai poco, dai quali non ti aspetti nulla di preciso, o nulla di buono.
Già, la sorpresa: che regalo intelligente da farsi!
Chi potrebbe mai, una volta che l’abbia letto, scordarsi, infatti, dell’incipit e del tremendo percorso al quale ti costringe “La metamorfosi”, di Kafka? Oppure il suo “Processo”?
Chi non è stato travolto dalle mille peripezie di Candido, o dalle scurissime vicende che avviluppano l’esistenza e l’animo dei personaggi dei “Demoni” di Dostoevskij?
Ognuno di noi ha la sua lista, grande o più modesta, delle letture che gli hanno stravolto la vita, lasciandolo ogni volta diverso da quel che era prima di leggerne la frase iniziale.
Molti anni fa, quando avevo già sulle spalle una carriera pluridecennale di lettore e avevo maturato la presunzione di essere ormai troppo cinico e smaliziato per essere colto di sorpresa o addirittura sconvolto da un libro, incappai in un romanzo che fornì una solenne smentita a questa mia certezza sventata.
Non ne conoscevo l’autrice e, anzi, mi sorprese perfino il suo nome, che pareva una parodia: Agota Kristof.
Di quel romanzo, “ Trilogia della città di K.”, avevo già sentito parlottare positivamente, ma in modo inconsueto: nel mio subconscio vagava il ricordo di qualcuno che lo aveva nominato, qualcuno che conoscevo e delle cui letture mi fidavo.
Anche degli articoli di giornale, letti tempo prima, corroboravano l’impressione che il libro dovesse essere qualcosa di insolito e che leggerlo potesse quindi tradursi in un’esperienza non comune.
Lo ignorai ancora per qualche tempo, mi decisi infine ad affrontare quel testo.
Dopo qualche pagina di lettura vorace avevo già la certezza di trovarmi dinanzi ad un capolavoro, un romanzo travolgente e stravolgente: fui certo che non avrei potuto dimenticarlo per il resto della vita.
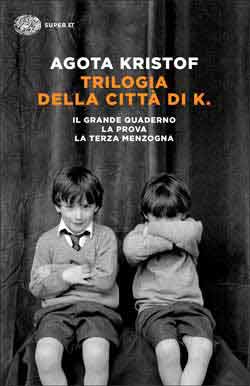
Come il titolo lascia capire, il romanzo è diviso in tre parti, “Il Grande Quaderno”, prima parte dell’opera, che venne pubblicata nel 1986; “La Prova”, uscita due anni dopo, e “La Terza menzogna”, l’ultima parte, pubblicata nel 1991.
Fu soprattutto la prima delle tre parti del libro a colpirmi con la forza di un pugno ben assestato.
Intanto per il fatto, abbastanza inedito, che i narratori sono due: due fratelli gemelli che a due voci raccontano la loro infanzia terribile, trascorsa in una città dal nome fittizio di K., che per via delle vicende che vi accadono si potrebbe identificare come una città dell’est europeo all’epoca dell’ultima guerra.
Affidati alla nonna da una madre che gli eventi hanno portato via, i gemelli crescono con questa donna durissima e avida, che solo col tempo dimostrerà, a suo modo, dell’affetto per i nipoti.
I due, ancorché piccoli, dimostrano un’intelligenza inquietante, precocissima, fuori del normale.
Nonostante l’età infantile, hanno molte incombenze: trascorrono giornate difficili, destinati a seguire faccende necessarie come tagliare la legna, pescare, badare all’orto o agli animali.
La loro raggelante genialità li porta però ancora più avanti, riescono così ad imparare varie lingue, a cantare e suonare.
Nel panorama precario di un paese schiacciato dalle crudeltà quotidiane, spicciole o grandi, della guerra, si è costretti a fronteggiare pericoli incombenti e ad avere a che fare con un’umanità eterogenee ed incattivita, prigioniera della Storia.
I due bambini si rendono conto presto che per sopravvivere in un contesto così duro, debbono mettersi in grado di reggere urti non comuni.
Così gli inquietanti gemellini cominciano a sottoporsi a prove ed esercizi di loro invenzione, prove durissime che li mettano in condizione di accrescere il loro grado di sopportazione fisica e morale.
Si insultano, dunque, e si picchiano per rendersi indifferenti al dolore fisico ed alle umiliazioni; digiunano per resistere alla fame, cercano il freddo per meglio abituarcisi e, soprattutto, annotano tutto ciò che accade a loro ed intorno a loro.
Lo fanno con una minuzia maniacale, coltivando un distacco freddo anche dinanzi ad episodi di estrema crudeltà e durezza ai quali assistono.

E’ il risultato di quella lontananza dall’empatia con le cose e gli uomini per raggiungere la quale si sono così duramente allenati.
Il risultato delle loro minute annotazioni è, appunto, il Grande Quaderno.
L’insensibilità acquisita attraverso tante prove autoinflitte, li aiuterà quando la madre, tornata a prenderli, morirà saltando in aria su una mina e i gemelli, che non hanno mai avuto davvero l’intenzione di seguirla, la seppelliscono senza soffrire, senza versare una lacrima.
In seguito alla ricomparsa del padre i due finiscono per separarsi ed anche questa divisione tra i gemelli viene descritta in modo terribile: i gemelli indicano la strada al padre, che vuole passare la frontiera, ma lo mandano per primo a tracciare il percorso.
Così, quando anche l’uomo salterà in aria, uno dei due gemelli, seguendone le orme, giungerà indenne dall’altro lato del confine.
Nelle due rimanenti parti del romanzo la realtà, così minutamente e realisticamente descritta nella prima, si fa meno perentoria.
“La prova”, seconda parte del romanzo, parla della vita del gemello rimasto nella città di K., ma il racconto da questo punto in poi si fa più nebuloso, mano a mano che tante vicende ed altrettanti personaggi andranno ad intersecare l’esistenza del personaggio superstite
Lucas, come viene infine chiamato il gemello residuo, viene trattato come un pazzo da tutti, un visionario, perché diviene di colpo incerta l’esistenza del fratello dal quale si è separato e del quale sente fortissima la mancanza.
La domanda inespressa del lettore viene però spontanea: il gemello che è andato via da K. è esistito e vive davvero da qualche altra parte, oppure si tratta di una proiezione immaginaria di quello rimasto?
Il dilemma sui gemelli, se siano stati due o uno solo, permea tutta la complessa narrazione successiva, rimanendo fino alla fine nebuloso.

La “Trilogia della città di K”, lo ribadisco, è un capolavoro, un romanzo indimenticabile, ed è un’esperienzadi lettura fuori del comune ed altamente consigliabile.
Con poche altre cose si cose impiega altrettanto bene il proprio tempo.
E’ altresì indubbio, a mio avviso, che la durezza del contenuto, che è parte integrante del fascino del romanzo, e la desolazione asciutta che viene fuori dalle sue pagine, richiedano tuttavia che il lettore si trovi in un momento di ottima forma psicologica.
E’ una precondizione per affrontare il testo cogliendone tutte le implicazioni.
Lo stile del romanzo è tanto secco, duro e privo di echi, da causare paradossalmente l’effetto opposto in chi legge, quello, cioè, di provocare una straordinaria compenetrazione col testo, di indurre a cogliere quasi fisicamente la mancanza di speranza che è il destino ineluttabile del mondo descritto, un mondo che evoca solo male e dolore.
La narrativa della Kristof, come si può dedurre, è del tutto priva di gigionismi, di imbellimenti, di strizzatine d’occhio: non accarezza mai il lettore per il verso del pelo, lo sconvolge semmai con una materia tanto dura quanto semplicemente esposta.
Impressiona pensare che la lingua in cui Agota scrisse la Trilogia, il francese, non era la sua lingua madre: lei infatti era ungherese.
La scrittrice nacque infatti nel 1935 a Csikvand, un villaggio piuttosto povero e trascurabile dell’Ungheria.
All’epoca dell’infanzia di Agota quel luogo era infatti, come riferisce lei stessa “privo di stazione, di elettricità, di acqua corrente, di telefono”.
Il suo temperamento curioso, vivace intellettualmente, ne favorì la precocità: a quattro anni imparò a leggere e scrivere correttamente e già da adolescente scrisse le sue prime poesie.
“Un mio personaggio, in “Ieri” dice che è diventando assolutamente niente che si può diventare scrittori. Devo dire che quest’affermazione vale anche per me.
Fin dall’infanzia ho amato leggere e scrivere.
Tutte le altre cose non avevano nessuna importanza, ma non volevo fare degli studi letterari, diventare un professore.
No, non amavo quella strada: ho preferito andare a lavorare in una fabbrica.
Lì potevo concentrarmi sulla scrittura, sui miei pensieri, vicino alla macchina che io usavo in fabbrica c’era un foglio su cui scrivevo i miei versi, ed era la cadenza delle macchine a darmi il ritmo di quella poesia…”.

In precedenza era stato il collegio femminile in cui venne mandata a studiare da adolescente, a segnare un distacco dalla sua felice infanzia contadina e l’approdo ad una realtà cittadina, un distacco che lei sentì doloroso, descrivendolo come l’inizio di “giorni cattivi”.
“La vita nel collegio è una pena, meglio allora scrivere un diario in una scrittura segreta perchè nessuno possa leggerlo”.
Sono anni di pianto, un pianto così prolungato che , dirà poi, esaurì per sempre le sue lacrime.
Piangeva per la inusuale reclusione e per la lieta infanzia perduta, per «le corse a piedi nudi per il bosco sulla terra umida fino alla “roccia blu”; svaniti gli alberi su cui arrampicarsi, da cui cadere quando un ramo marcio si rompe”.
Sposatasi, diversi anni dopo, nel 1956, si trovò ad affrontare la rivolta ungherese contro l’invasione russa.
Si creò una situazione che suo marito giudicò pericolosa, tanto da convincerlo a fuggire con la moglie e la figlia nata nel frattempo.
Con la famiglia quindi, Agota raggiunse la Svizzera, stabilendosi a Neuchatel, città in cui resterà vita natural durante, ma non perdonò mai il marito per averla strappata al paese natale:
“Io non volevo lasciare il mio paese. Lo rimprovero sempre al mio ex marito: era lui che aveva paura dopo i fatti del ’56, io non avevo nulla da temere, lavoravo in fabbrica e amavo scrivere. All’inizio non capivo cosa c’entravano per me la Svizzera, la lingua francese. E’ stata una separazione difficile, soprattutto quella della mia lingua, ma non potevo continuare, come hanno fatto alcuni altri scrittori dell’Est a scrivere in una lingua che non parlavo più quotidianamente. Non avrei avuto neppure lettori. E così scrivere in francese è stata una necessità oltre che una sfida. Mi dicevo: “come può accadere questo, io che sto scrivendo in una lingua che non è la mia”. Era un po’ un miracolo. Oggi mi capita di ritornare in Ungheria, ho pure il doppio passaporto, ma per brevi periodi, io vivo in Svizzera vicino ai miei figli…
( da un’intervista concessa a Michele De Mieri per l”Unità”).
Come si evince dalle sue parole, fu il francese la lingua che La Kristof adottò per la sua produzione letteraria, uno sforzo che costò molto ad una natura perfezionista come la sua, ma che portò ad esiti espressivi stupefacenti, soprattutto nel suo libro fondamentale, “La Trilogia della città di K.”, in cui riuscì a dare alla scrittura quell’asciuttezza dura per cui è rimasta famosa.
Nella stessa intervista citata, a proposito del suo stile secco, Agota rivela:

“All’inizio non era per niente così. Anche quando scrivevo in ungherese ero melliflua, romantica, troppo letteraria. Le mie prime cose in francese, quelle per il teatro, erano scritte in una lingua normale, quotidiana. Solo quando ho cominciato a scrivere i capitoli della prima parte della Trilogia ho cercato fortemente un nuovo linguaggio: dovevo rendere lo stile di un libro scritto da dei bambini (i due gemelli n.d.r.), anche se un po’ speciali, molto intelligenti e autodidatti, che amano i dizionari com’eravamo io e mio fratello. Per la verità chi mi ha messo definitivamente sulla buona strada è stato mio figlio quando aveva dieci, dodici anni, io l’osservavo molto scrivere, studiavo il modo e il contenuto, e cercavo di apprendere quello stile, quel punto di vista. Il mio stile è figlio di mio figlio… “. (stessa intervista citata ndr)
Come si è detto, la Kristof è poi vissuta in Svizzera per il resto della sua vita e al capolavoro che l’ha resa celebre, andarono ad affiancarsi altre opere, non numerosissime perché lei in fondo non è stata una scrittrice prolifica, forse a causa del suo perfezionismo.
“Ieri”, altro suo romanzo, una storia d’amore durissima, uscì nel 1995, seguito da “ L’analfabeta”, un racconto autobiografico del 2004, e da “La vendetta”, pubblicato l’anno successivo.
Anche quest’ultima opera si componeva di vari racconti, caratterizzati dallo svolgersi dei temi cari alla Kristof, incluso, ancora una volta dopo la Trilogia, quello di un mondo senza speranze in cui la crudeltà degli adulti si rispecchia in quella dei bambini.

L’opera narrativa della scrittrice si chiuse con “Dove sei Mathias” un libro composto da due racconti che rimandavano a tutte le sue ossessioni: l’infanzia perduta, i colpi del tempo, la disperazione nei confronti della vita.
Quattro sono le opere teatrali scritte dalla Kristof: “John e Joe. Un ratto che passa” che pubblicò nel 1972; “La chiave dell’ascensore”, del 1977; “L’ora grigia” del 1975 e “L’espiazione. L’epidemia. Due pezzi teatrali”.
Nel 2016 venne pubblicata postuma la raccolta di poesie “Chiodi”.
Agota Kristof, infatti, era scomparsa qualche anno prima, nel 2011.
Dopo la morte è tornata definitivamente in Ungheria ed è sepolta a Koszeg.
Sopra le case e la vita
nebbia grigia lieve
con le foglie a venire
degli alberi nei miei occhi
aspettavo l’estate
più di tutto
dell’estate amavo la polvere la bianca
calda polvere
insetti e rane vi morivano soffocati
se non cadeva la pioggia
per settimane
un prato e piume viola sul prato
crescono
gli uccelli il collo dei pozzi
il vento stende sotto una sega
chiodi
puntuti e smussati
chiudono porte montano grate
tutt’attorno sulle finestre
così si edificano gli anni così si edifica
la morte
Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.
Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.
Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.
Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.
Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.
Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:
“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.


