
“Gli uomini nascono al pianto e io voglio uscire dal deserto e alla fine raggiungere il mare aperto e libero”.
Il 17 ottobre del 1910, in un caldo pomeriggio goriziano, un giovane di appena ventitré anni decise di togliersi la vita sparandosi un colpo di rivoltella alla testa.
In quello stesso giorno aveva ultimato e spedito la sua tesi di laurea.
Sono passati più di cento anni da allora, ma il “mito” di quel giovane non è sopito, come pure la forza delle sue idee precoci.
Oltre alla tesi “la persuasione e la rettorica” di lui conosciamo poco altro: un suo “Dialogo sulla salute” e le “Poesie”.
Ha inoltre lasciato una quantità smisurata, data l’età, di racconti abbozzati, dipinti, disegni, traduzioni dal greco e dal latino (lui che cercava di pensare in queste lingue), saggi iniziati con folgorazioni improvvise.
Opere tutte intrise da un senso schopenhaueriano di dolore, di inutile lotta per la propria sopravvivenza, di malinconia cosmica.
E’ stato un filosofo e poeta mai compreso fino in fondo, oggetto di riflessioni viziate dal pregiudizio e spesso slegate dai fatti: nel 110° anniversario dalla morte di Carlo Michelstaedter, la studiosa goriziana Chiara Pradella ha cercato di ristabilire un equilibrio nella interpretazione della vita e delle opere dell’intellettuale goriziano offrendo più di uno spunto di riflessione nel libro “110. Carlo Michelstaedter e il tempo della Verità”.

L’autrice rigetta la tesi, alla diffusione della quale molto ha contribuito Giovanni Papini, parlando di “suicidio metafisico”, che Michelstaedter sia stato un “filosofo della morte”, perché indagando tra pagine e pagine di documenti, libri e archivi e compiendo una ricerca sul campo, l’autrice ha ricostruito tassello dopo tassello l’intera vicenda del filosofo, giungendo alla conclusione che non ci fosse da leggere alcuna predeterminazione al suicidio nei suoi lavori.
Michelstaedter infatti si sarebbe sparato alla tempia solo perché consapevole delle conseguenze della sifilide, malattia che ne aveva minato il corpo ma anche, nell’ultimo stadio, l’animo.
Nessuna volontà filosofica per la morte: al contrario, Michelstaedter amava la vita profondamente e, accettando il dolore e il proprio irreversibile destino, aveva l’urgenza di scrivere il più possibile i suoi pensieri sul mondo e sull’esistenza, ma anche di dipingere, prima che fosse tardi.

La cattiva interpretazione dei fatti della sua morte ha portato negli anni a una fuorviante analisi anche dei lavori del talento goriziano, come se non fosse possibile leggerne l’opera omnia senza quella lente del suicidio, senza così offrire una riflessione alternativa di adeguata profondità.
In questo contesto si inserisce il lavoro della Pradella, condotto con serietà e passione per Michelstaedter (l’autrice si è anche battuta per salvare dall’incuria la soffitta a Gorizia dove visse il poeta), ma senza alcuna volontà di mitizzare minimamente l’intellettuale.
La volontà della studiosa è solo quella di raccontarlo in modo esaustivo, partendo proprio dai suoi ultimi anni di vita, di sottolineare la sua genialità accompagnata dalla sofferenza, dalla gioia di abbeverarsi alla vita e di coglierne il più possibile, pur nella consapevolezza della malattia inesorabile.
Ed è proprio qui che risiede la modernità e l’importanza del filosofo, proprio per il suo messaggio positivo. E’ questo che viene infatti sottolineato da una sua riflessione eloquente:
“lavora su te stesso, fai quanto ti è più possibile per riuscire ad andare avanti in autonomia; però ricorda che la fiamma che riuscirai a sprigionare con il tuo essere non sarà solo utile a te, ma anche a illuminare il cammino di tutti quelli che ancora non sono stati capaci di crearla, la scintilla”

Scrive la Pradella che le parole sono pietre, come diceva Carlo Levi, e della loro consistenza fa quindi il principale strumento di quella che Michelstaedter, opponendola alla “persuasione” e cioè al pieno possesso della propria vita, aveva definito la “rettorica”: tutto l’insieme,cioè, di finzioni, menzogne, ipocrisie, inganni e autoinganni (la cosiddetta “comunella dei malvagi”, come la definì lui stesso) che regola i traffici sociali e che impedisce di chiamare le cose col loro nome.
La conseguenza è di raggelante semplicità: se non c’è -perché non ci è data- una verità autentica delle cose, se non si vive “la” verità delle cose” e “nella” verità delle cose, la vita stessa finisce nei gorghi della “rettorica” e non è degna perciò di essere vissuta.
Il che è vero, almeno in linea di principio, vale a dire che, se non si prendono in considerazione i possibili contrappesi in virtù dei quali la “persuasione” diventa senza dubbio meno “persuasione”, anche la “rettorica” diventa un po’ meno “rettorica”.
Ma Michelstaedter non tollerava i compromessi e le mezze verità.

Il suo era un tipico destino austroungarico: nato a Gorizia nel 1887, genio precoce e figlio di quella Mitteleuropa ebraica che ha gettato uno scandaglio di rara precisione nelle profondità più impervie della condizione umana, Michelstaedter ha vissuto fino alle estreme conseguenze la fatale mancanza di sintesi tra “persuasione” e “rettorica” e si è suicidato appena dopo aver portato a termine la sua tesi di laurea.
La tesi, intitolata appunto “La persuasione e la rettorica”, conserva a distanza di oltre un secolo una strana e perfino sinistra fascinazione, perché da un lato, considerata dalla prospettiva attuale, si inscrive quasi naturalmente in una più ampia riflessione di quegli anni sul disagio della civiltà, ma dall’altro fornisce l’impressione di un meteorite proveniente da chissà dove, da lontananze cosmiche che nemmeno i suoi maestri Ibsen e Tolstoj si erano spinti ad esplorare.

Henrik Ibsen 
Lev Tolstoj
Per Ibsen e Tolstoj, infatti, pretendere di vivere nel pieno possesso della propria esistenza è da megalomani, ma lo sforzo merita comunque di essere intrapreso, non fosse altro che per constatarne il fallimento, mentre per Michelstaedter è impossibile.
Niente vale niente, non c’è nessuno sforzo da intraprendere: il peso che tende per forza di gravità verso il basso, cessa di essere tale nel momento in cui raggiunge il proprio scopo:
“So che voglio e non ho cosa io voglia. Un peso pende ad un gancio, e per pender soffre che non può scendere: non può uscire dal gancio, poiché quant’è peso pende e quanto pende dipende (…) Che se in punto gli fosse finita e in un punto potesse possedere l’infinito scendere dell’infinito futuro, in quel punto non sarebbe più quello che è: un peso. La sua vita è questa mancanza della sua vita”.
L’esistenza è quindi una contraddizione insolubile, e il suo scopo è la sua negazione: il non essere, il nulla, la morte.
Notevole è “l’Epistolario”, più volte riedito e aggiornato da Adelphi fino all’ultima edizione del 2010, nel quale figura integralmente la terribile lettera al padre del 31 maggio 1908, quella in cui Carlo gli indica le sofferenze e i guai di un “altro affare”, ossia dell’aver contratto la sifilide in un bordello.
Una sofferenza e un’umiliazione, tanto più grande per uno che proveniva da una famiglia ebraica di stretta osservanza religiosa, e che non dovette essere senza conseguenze psicologiche.
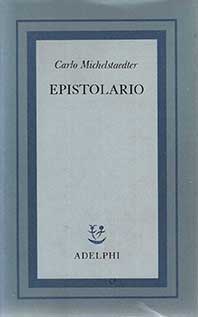
E se invece l’accesso alla persuasione fosse fornito dalla sola poesia?
Nell’ambito della produzione poetica di Michelstaedter, ovviamente concentrata in pochissimi anni, i componimenti lirici, scritti tra il 1900 e il 1910, occupano uno spazio apparentemente marginale, ma in realtà sono importanti e molto rivelatori.
In primo luogo, perché tentano di circoscrivere e avvicinare la “persuasione” per mezzo della poesia, e poi perché fanno percepire in una forma, più diretta, la medesima vibrazione che si avverte leggendo la sua tesi e gli altri scritti.
Se i primi componimenti lirici si rifanno a taluni modelli allora in voga, le poesie del secondo e ultimo periodo sviluppano su un altro registro il tema di fondo de “La persuasione e la rettorica”: la ricerca della vita assente: “arida e deserta, / finché in un punto si raccolga in porto, / di sé stessa in un punto faccia fiamma”.
Il mitteleuropeo Michelstaedter nelle sue liriche individuava una possibile “persuasione” nell’infinità della distesa marina, ma la sostanziale contraddizione della vita risultava irrisolvibile anche sul piano poetico: se la “rettorica” era il “mondo”, la “persuasione” si identificava con l’assoluto del mare, e cioè con una dimensione esterna irriducibile al suddetto “mondo”.
Ma il mare non può che affermare il nulla e anzi essere il simbolo stesso del nulla e dell’annullarsi, come si nota nell’ultima poesia dedicata all’amato Isonzo, che appunto scorre e tende al mare, dove infine si perde, trovando finalmente il proprio scopo.

Il genio di Carlo Michelstaedter continua a parlarci da una vicinissima galassia, nella quale logica e poesia convergono nell’affermare il nulla.
C’è però un antidoto contro questa sua terribile verità: la vita reale, che fin troppo spesso non è logica, e men che meno poetica.
Il giovane Carlo, tuttavia, non era disposto ad accettarlo:
“se vincere è impossibile, sopravvivere non conta”,
come diceva Rilke.
Carlo Michelstaedter, come si è detto, grande ingegno, letterato e poeta, nacque appunto a Gorizia il 3 giugno del 1887, ultimogenito di quattro figli, (gli altri erano Gino, Elda, Paula), da una benestante famiglia borghese di origini ebraiche.
Tra gli altri membri della famiglia è da ricordare inoltre Carolina Luzzatto, prima donna italiana ad aver diretto un quotidiano.
Carlo Raimondo (Ghedalià Ram) era il nome che gli venne imposto.
Della sua infanzia sappiamo poco: la sorella Paula lo ricordava come un bambino pauroso del buio e dell’altitudine, mai disposto a chiedere scusa per qualche torto fatto.
Il padre, Alberto, colto e laico, era un tipico rappresentante della borghesia asburgica ottocentesca e lo educò con severità, permettendogli, però, di affinare le sue tendenze precoci.
Carlo, infatti, frequentò lo Staatsgymnasium, seppur senza brillare.
Ben presto s’interessò alla filosofia, discutendone vivacemente col suo professore, Richard von Schubert-Soldern, e con l’amico Enrico Mreule, che gli fece leggere “Il mondo come volontà e rappresentazione” di Schopenhauer, che tanta influenza ebbe sulla sua successiva speculazione filosofica.
Amava il Vangelo, Platone, Leopardi, Tolstoj e il nordico Ibsen, al quale si sentiva particolarmente affine per la formazione educativa.
S’iscrisse prima alla facoltà di Matematica dell’Università di Vienna, poi a Lettere presso l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, città in cui visse per quasi quattro anni e in cui conobbe professori famosi e straordinari condiscepoli.
In questo periodo iniziò a scrivere in modo quasi compulsivo sia testi letterari che opere filosofiche, sia lettere agli amici che alla sorella Paula, arso da un fuoco creativo inesauribile.

Tentò senza successo di entrare nella redazione di qualche giornale ma pubblicò due articoli sul “Corriere friulano”, diretto dalla zia Carolina Luzzatto (una recensione su D’Annunzio e su Tolstoj), e un articolo sul “Gazzettino popolare” (sullo “Stabat Mater” di Pergolesi).
Nel 1907 una sua relazione sentimentale con la compagna di studi Iolanda De Blasi era stata ostacolata dal padre col quale i rapporti erano diventati sempre burrascosi, appena un anno prima della sua morte era scomparso tragicamente, per un sospetto suicidio, il fratello più grande Gino, emigrato a New York.
Il suo destino sembrò segnato da quest’atto tremendo. Soltanto due anni prima si era suicidata anche una donna da lui molto amata, Nadia Baraden di origini russe.
Nell’ottobre dello stesso anno l’amico Enrico Mreule partì per l’Argentina. Questa partenza fu segnata da un evento significativo, una sorta di passaggio del testimone: Carlo si fece consegnare da Enrico la pistola che da allora portò sempre con sé.
Michelstaedter si legò poi sentimentalmente ad Argia Cassini, un’amica della sorella Paula, pianista di talento: i due condividevano la passione per Beethoven, nella cui musica Carlo avvertiva
“una gioia tragica, che spaventa e lascia annichiliti”.

Argia Cassini resterà sempre fedele alla sua memoria.
Si manifestarono a quei tempi le sue prime turbe comportamentali favorite dalla consapevolezza di essere affetto dalla sifilide, così si rinchiuse in un isolamento quasi ascetico, rifiutando ogni piacere o comodità, e sottoponendosi a severi digiuni.
Poi, il 17 ottobre, dopo un litigio con la madre, Carlo prese l’inseparabile pistola e nel pomeriggio si sparò.
Sulla copertina della sua tesi, aveva disegnato una lampada a olio e aveva scritto in greco “apesbésthen (io mi spensi)”.
Fu ritrovato dopo due ore dal cugino Emilio e spirò prima di notte senza riprendere conoscenza.
Venne sepolto nel cimitero ebraico di Rožna Dolina, che oggi si trova nel comune sloveno di Nova Gorica, nelle vicinanze del confine italiano.

Nessuna ragione “metafisica” dunque: Carlo Michelstaedter con ogni probabilità si uccise perché afflitto da una grave forma di sifilide, e il suo fu un suicidio a lungo meditato durante il corso del male, come testimoniano i libri dedicati al tema del suicidio, della pazzia e dell’isteria (di autori quali Antonini, Casoni, Cassino, Caramanna) tutti del 1906-1909, da poco scoperti nella biblioteca ritrovata di Michelstaedter e ora confluiti nelle collezioni della Biblioteca Statale Isontina.
La storia del ritrovamento di questi volumi è affascinante: furono infatti riposti con amore da Elda, sorella di Carlo, in un cassone che miracolosamente scampò alle perquisizioni delle SS durante la seconda guerra mondiale e di cui poi sbiadì la memoria.
La cassa era stata affidata nel 1943 alla famiglia di Franca Bertoldi, conoscente dei Michelstaedter e Franca tutt’ora ricorda come la nonna le parlasse di questo cassone come di un bene da tenere con cura.
Come emerso dal contenuto della cassa, il colpo di rivoltella che pose fine all’esistenza del goriziano sarebbe partito per evitare le sofferenze legate al progredire della sifilide, patimenti che avrebbe inferto a sé e alla sua famiglia.
“Chi teme la morte è già morto”.
Bibliografia:
Chiara Pradella, “110. Carlo Michelstaedter e il tempo della Verità”, Ensemble 2020;
Sergio Campailla, “Un’eterna giovinezza”, Marsilio, 2019;
Carlo Michelstaedter, “poesie”, Adelphi, Milano 1987;
Carlo Michelstaedter, “La Persuasione e la Rettorica”, Adelphi, Milano 1982.
Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.
Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.
E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.
Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.
Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.
Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.
Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.
Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.
Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.
Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…
Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.


