
“la vera originalità consiste nel cercare di fare come gli altri, senza riuscirci mai”.
In quarant’anni di carriera, Robert Bresson ha affrontato i temi chiave del cinema moderno europeo: la sofferenza, la solitudine, il male, ma anche la speranza in una remota possibilità di redenzione.
Alle opere di questo grande maestro, che di fatto ha inventato un linguaggio cinematografico personalissimo e alieno da ogni concessione allo spettacolo, la più bella dedica la fece, prima di morire, il regista tedesco iconoclasta per eccellenza, Fassbinder che, senza dire neanche una parola, pose come incipit del suo ultimo film “La terza generazione”, lo schermo di un televisore dove passavano inesorabili le scene finali di quello che è probabilmente il capolavoro di Bresson, “Le diable probablement”.
Era il riconoscimento al contributo tormentato di questo regista ai temi sociali e spirituali del secolo appena finito.
Cosa è stato il cinema di Robert Bresson?
La risposta è forse nelle sue parole:
“Che cos’è il cinema? Ritmi e, al tempo stesso, rapporti, incrociarsi di rapporti, di opposizioni, di colpi, di scambi tra un’immagine e tutte le immagini, tra un’immagine e il suono…
Film cinematografici dove le immagini, come le parole del dizionario, non hanno potere e valore che per la loro posizione e relazione…”.

Il suo era un cinema che procedeva secondo un processo di purificazione degli elementi compositivi , dove la riduzione a segno degli oggetti, dei gesti, dei suoni, dei volti mirava a un’esaltazione del particolare che diventava la cifra interpretativa, ed era una dichiarazione d’amore verso il cinema inteso come ricerca. Ma era anche un linguaggio che scrutava, analizzava e rendeva visibile il destino dell’uomo in una messa in scena che puntava all’astrazione e allo stesso tempo conservava intatto il senso del reale. L’invenzione del silenzio era per Bresson la scoperta di un vero e proprio nuovo umanesimo.
In poche pellicole il regista ha raffigurato tutti i principali sentimenti umani, dai più nobili ai più meschini, trasfigurandoli in un’aurea di poesia influenzata da una visione pascaliana del mondo, se non addirittura giansenista.
Il cinema di Bresson è sempre stato enigmatico.
È dominato fin dall’inizio da un’urgenza spirituale che negli anni si affina, si ostina, fino a farsi blocco. Richiede una disposizione intellettuale e antisentimentale, proprio ciò che nel cinema è molto innaturale. Non ci permette mai di accomodarci nella dolcezza di un’immagine, ma allo stesso tempo è capace di produrre una risonanza emotiva che coglie impreparati, e perciò tanto più profondamente scava.
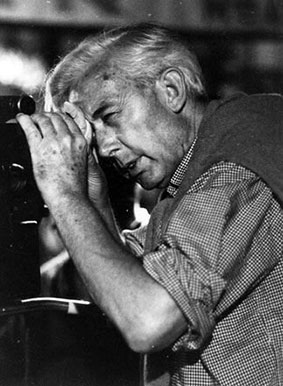
“Robert Bresson pensava che il cinema permettesse, per la sua stessa natura, di rivelare qualcosa legato all’interiorità, qualcosa di molto nascosto, volontariamente o involontariamente. Qualcosa, in qualche modo, di non cosciente, che appartenesse al mistero che avvolge ogni essere umano. Così, proprio per questa sua complessità d’intenti, il cinema di Bresson nasceva ben prima delle riprese e non si concludeva con l’ultimo giorno sul set”.
Gli attributi che meglio descrivono l’arte di Bresson sono il rigore e la coerenza. La sua presenza all’interno del mondo del cinema è stata sempre segnata da una totale negazione delle logiche produttive che governano l’industria visiva. Cosa che gli ha procurato spesso difficoltà a reperire i fondi per mettere in scena i suoi film.
Prima di lui infatti il cinema, soprattutto quello francese, era uno spettacolo con regole abbastanza codificate: una sceneggiatura ben scritta, un modello narrativo che guardava soprattutto al romanzo, con un intreccio coerente e dialoghi attenti nel caratterizzare le tipologie umane.
Bresson stravolse tali regole con “Pickpocket” del 1959, film che segnava alcune conquiste fondamentali per il cinema: il rifiuto dell’intreccio e dell’interpretazione classica, la scoperta delle riprese in esterno e una percezione soggettiva del racconto, vale a dire la presenza della voce dell’autore nel racconto ed il sopravvento della immagine rispetto alla parola.
Ma si trattava di caratteri a cui Bresson arrivò per gradi.

Il “Diario di un curato di campagna” (1950) era stato il primo film maturo di Bresson, in cui si cominciava a chiarire il suo stile particolare, nel quale forme, personaggi e dialoghi erano costruiti secondo una logica della sottrazione del superfluo per far posto solo all’essenziale.
Nel “Un condannato a morte è fuggito”, del 1956, Bresson scoprì il potere dei suoni. All’inizio inseriva la musica quando i personaggi smettevano di parlare, poi assecondava quanto dicevano inserendo, a seconda dei casi, Mozart e Monteverdi; in seguito rinunciò a commenti e suoni per ascoltare i rumori per, sostituirli a volte alle frasi. Il risultato che ne venne fuori, seppure spiazzante, aveva il fine di eliminare qualsiasi tipo di distrazione, per instaurare un rapporto stretto tra l’attenzione di chi guardava e le indicazioni di chi mostrava
Un tema particolarmente amato era quello della solitudine, che esprimeva sempre emarginazione, estraniamento rispetto al mondo circostante. Una condizione d’animo che vivranno quasi tutti i personaggi bressoniani: oltre a Giovanna d’Arco e al condannato a morte, anche “Mouchette”, nel film omonimo e la protagonista di “Così bella così dolce”, e il giovane Charles ne “Il diavolo probabilmente”.

Sono tutti esseri che vivevano in un mondo crudo, in cui i rapporti tra le persone e il loro valore spirituale rischiavano di essere completamente annullati. Una condizione che generava sofferenza, impotenza nel non riuscire ad esprimere una diversità fatta di desiderio, esplorazione della propria interiorità etica e capacità di utilizzare il dolore come strumento vivo di conoscenza.
Dietro tutto questo c’è una spiritualità quasi mistica, nutrita di forte pessimismo, che da un film all’altro, annullava qualsiasi elemento di speranza. Quella progressione che ha accompagnato Bresson nella sua ricerca, era presente, infatti, anche nella sua evoluzione tematica, nel senso che la sua visione della società diventò progressivamente più cupa ed al suo interno, sarà sempre più difficile trovare spazi di espressione distesa e attimi di velata speranza.
Da “Au hasard Balthazar”, del 1966, qualcosa sembrò chiudersi: da questo film in poi il dualismo tra le regole del mondo e la libertà della morale si risolveva, in maniera disperata, sempre a danno della seconda.

Un assunto presente anche nel penultimo film del 1977 “Il diavolo, probabilmente”, in cui la voglia di vivere di un ragazzo si infrangeva di fronte alla realtà che lo circondava, che gli appariva come dominata da una forza oscura e terribile. Non gli erano di conforto nè davano risposte convincenti la religione, l’amore, la politica: tutte le illusioni dei decenni precedenti erano penosamente cadute. Il giovane cominciava a pensare al suicidio, come gli antichi romani che si facevano ammazzare da uno schiavo. Lui si farà assassinare in un cimitero da un coetaneo. Questo film terminava con il sacrificio del giovane Charles che non apriva la via a nessuna redenzione: Charles moriva senza speranze.
Nato in un paesino della Francia centrale nel 1907, Bresson si laureò in Filosofìa alla Sorbona di Parigi. Pittore, si accostò al cinema quasi per caso, assistendo alla realizzazione di alcuni film e sull’onda della sua amicizia con gli esponenti del surrealismo che lo convinsero a riprendere il clown Beby nel cortometraggio “Les affairs publiques”. Dopo più di un anno trascorso come prigioniero di guerra in un campo di concentramento tedesco, Bresson tornò al cinema nel 1943 e firmò il suo primo lungometraggio, “La conversa di Belfort”, cui seguì l’anno seguente “Les dames du bois de Boulogne”, tratto da un racconto di Diderot con i dialoghi di Jean Cocteau.
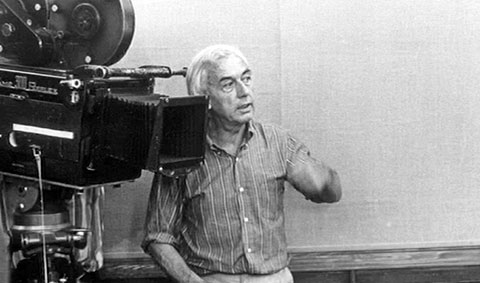
E’ con “Diario di un curato di campagna”, premiato a Venezia nel 1950 e tratto da un testo di Bernanos, che Robert viene considerato dai Cahiers du Cinema un fondatore della nouvelle vague, visto anche il fatto che egli quasi molto spesso sceglie i suoi attori fra gente della strada.
Il 1956 fu l’anno del suo film “Un condannato a morte è fuggito”, tratto da un racconto di André Devigny comparso su Le Figaro Littéraire del 20 dicembre 1954;
il film venne girato con scarsi mezzi e si concentrava su pochi, essenziali oggetti e luoghi diventando una delle testimonianze più asciutte ed essenziali sulla Resistenza francese. L’anno successivo vinse il premio per la miglior regia al Festival di Cannes.
Nel 1962, Bresson girò “Processo di Giovanna d’Arco”, forse il suo film più difficile, in cui l’essenzialità era spinta al massimo. Più importante forse il successivo “Au hasard Balthazar” (1966), una parabola sulla vita e la morte di un asino che diventava una riflessione sul male e sulle sue influenze nella vita degli uomini.
“Mouchette – Tutta la vita in una notte”, del 1967, anch’esso tratto da un romanzo di Bernanos, era parimenti una cupa riflessione sul male attraverso la storia del suicidio di una giovane donna, e una meditazione sulla presenza di un Dio esistente ma non umanamente conoscibile, come avevano scritto già Kafka e Kierkegaard.
“Così bella, così dolce” (1969) descrive ancora la morte di una giovane donna, e, in flashback, la storia della sua vita di coppia nella piccola borghesia parigina. Per la prima volta Bresson in questo film fece uso del colore, e per la prima volta comparve sullo schermo la giovane Dominique Sanda, una delle pochissime interpreti bressoniane che avranno in seguito una grande carriera di attrice.

“L’argent”, suo ultimo film, era una riflessione su come un’azione disonesta possa portare a conseguenze catastrofiche la vita di colui che ne è vittima.
Bresson si ritirò definitivamente a vita privata negli anni Ottanta, dopo aver fallito il tentativo di trovare un produttore per il suo progetto di realizzare una pellicola dal Libro della Genesi.
E’ morto per cause naturali, a 92 anni, a Parigi.
Presentare la figura di Bresson è ancora oggi una delle sfide più complesse dell’intera storia cinematografica. La stratificazione del suo pensiero, i suoi studi rivolti alla condizione esistenziale umana descritta attraverso il potente mezzo del cinema, lo hanno reso in tutta la seconda metà del Novecento, una figura basilare per il cinema mondiale, iniziatore di una tra le correnti più influenti: la Nouvelle Vague.
Autore minimalista, il suo cinema è intriso di una forte componente mistica e può essere condensato in un’investigazione sulla possibilità del Cristianesimo di impronta giansenista che si proponeva di analizzare quella che, di fatto, è la presenza divina.
Bresson tiene sotto scacco lo spettatore proponendogli continui moniti, che vogliono rappresentare i principi cardine del suo pensiero: lo svelamento della perdita dell’innocenza, l’inavvicinabilità ed il silenzio di Dio, la progressiva distruzione fisica del mondo oltre che quella morale e sociale operata dall’uomo, il tutto accompagnato da una lacerante solitudine quasi bergmaniana, sino all’esplosione inevitabile del male, aldilà di ogni volontà e di ogni buona intenzione.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.
Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.
E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.
Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.
Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.
Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.
Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.
Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.
Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.
Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…
Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.


